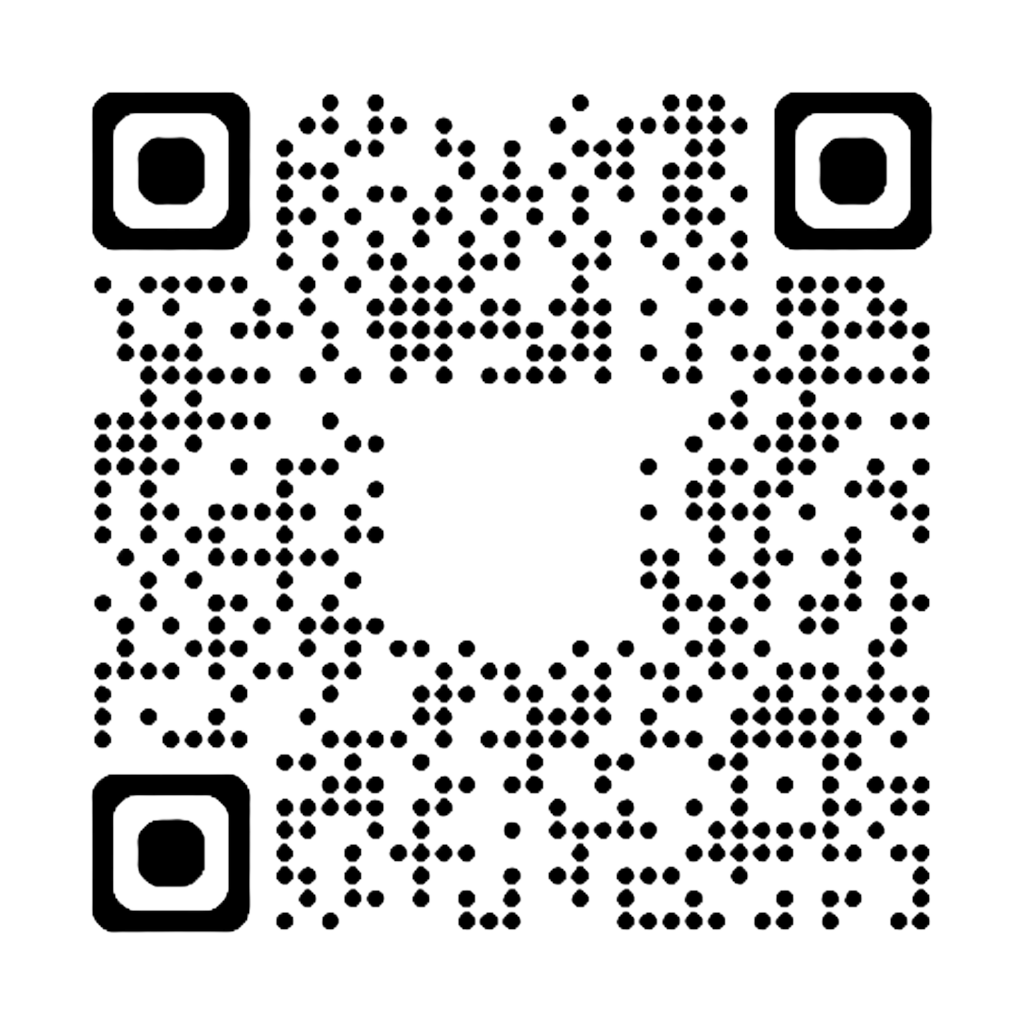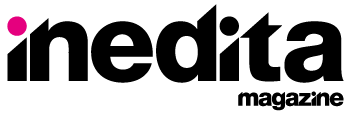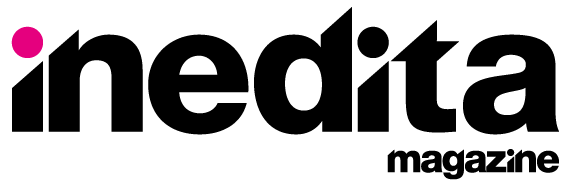Si pensa sempre che sia il tocco a fare male al corpo, ma mai il non essere toccati.
Una verità, invece, scontata per chi è detenuto, privato anche del contatto umano, dell’affetto dei cari e di uno spazio preposto all’affettività e alla sessualità.
Una privazione che, come stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 10 del 2024, lede la dignità della persona e rappresenta un ostacolo alla finalità rieducativa.
Un’assenza che nuoce indirettamente anche coloro che non hanno commesso alcun reato e, pertanto, subiscono una pena non meritata: i familiari.
Oltre a questo, la stessa detenzione comporta che le pulsioni sessuali siano più intense, la cui impossibilità di soddisfacimento rende il carcere anche un luogo di violenze sessuali.
Un luogo, il carcere, dove farsi la doccia diventa pericoloso.
Una decisione che è rimasta inascoltata, nonostante il mondo dell’architettura penitenziaria abbia e continui ad offrire soluzioni architettoniche idonee a costruire spazi riservati; fra questi,” la Casetta Rossa” di Renzo Piano presso il carcere femminile di Rebibbia – storicamente un carcere di avanguardia architettonica ad opera dell’architetto Lenci – progetto anticipato negli anni ‘80 dal “Giardino degli Incontri” di Sollicciano, pensato dall’architetto Michelucci che volle portare uno spazio cittadino – un giardino – all’interno del carcere con la speranza di colmare quel vuoto emotivo fra la società e il carcere, allontanato dalla vita e dalla coscienza sociale con apposite scelte urbanistiche funzionali alla creazione del mostro da distaccare, anche fisicamente, dalla propria immagine.
Anche la stessa struttura del carcere influisce, negativamente o positivamente, sull’afflittività della pena e sulla dignità della persona riflettendo contestualmente la concezione culturale della pena stessa: allora basta osservare degli istituti carcerari per prendere coscienza che la pena non è volta alla rieducazione del condannato come impone la nostra meravigliosa Costituzione, la quale, ai sensi dell’art. 27 stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato e ancora, ex art. 24, si punisce ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
Già dal momento dell’ingresso in carcere, perché mero contenitore di cemento, si assiste ad un’involuzione di tutta la sensorialità.
Il corpo è compresso per l’enorme numero di sovraffollamento. Perde la propria interezza: non ci sono specchi di natura intera all’intero delle carceri. Sembra irrilevante finché non si immagina quanto, dopo anni, possa far venire meno il senso di sé e il rapporto naturale con il proprio corpo, mai più integralmente riflesso.
Lo sguardo si accorcia abituandosi a muoversi su distanze ridotte; la vista si accorcia a causa delle finestre fatte di sbarre e reti metalliche e l’occhio così perde la capacità di muoversi su lunghe distanze e di mettere a fuoco i dettagli.
Un luogo di continui rumori metallici, come il tintinnio delle chiavi giganti delle guardie penitenziare o i cancelli che si aprono e si chiudono, costanti e pervasivi che compromettono l’udito che si acutizza ( c.d. Stato morboso di iperacutezza e colpisce il 60% dei detenuti ) il quale può, per difesa, trasformarsi in sordità.
L’olfatto può anestetizzarsi a causa di odori umidi e stagnanti respirati in maniera continuativa.
La capacità tattile viene modificata dalla scarsità di stimoli sensoriali, diversi dal cemento e dal ferro.
La mente viene compromessa da specifiche patologie carcerarie, note come le c.d. Sindromi da Prisonizzazione (processi di erosione dell’individualità cui consegue la comparsa di nuclei depressivi, dissociativi, distruttivi dell’autostima e dell’autoconsapevolezza, spesso con gravi esiti patologici).
La pena colpisce la mente non soltanto psicologicamente, ma fisicamente.
Infatti, studi in campo neuroscientifico hanno dimostrato come l’esperienza prolungata dell’isolamento può addirittura modificare la struttura anatomica e le funzionalità celebrali: la neuroscienziata Huda Aki ha studiato il caso Robert King, che dopo avere trascorso 29 anni in cella di isolamento, aveva perso le proprie capacità di orientamento spaziale. La studiosa aveva ipotizzato che il protrarsi dell’isolamento avesse compromesso la zona dell’ippocampo, area fondamentale per la memoria e il riconoscimento spaziale. La mancanza di relazioni può quindi trasformare l’anatomia del cervello e ridurre la massa di alcune regioni critiche per il pensiero, il controllo delle emozioni e alterare la connettività fra amigdala e lobi frontali aumentando così i disturbi del comportamento.
Il carcere, infine, nuoce anche alla voce. E, allora, nel tentativo di poter in qualche modo rimediare, lascio lo spazio e la voce a chi il carcere lo ha vissuto: in questo caso a Marco Sorbara che ringrazio.